 Clicca qui per leggere l’articolo, apparso sul Quotidiano di Puglia del 19 settembre, sul nuovo album di Marco Schnabl.
Clicca qui per leggere l’articolo, apparso sul Quotidiano di Puglia del 19 settembre, sul nuovo album di Marco Schnabl.
Archivi categoria: Scritti
Nessuno scompare davvero: l’intervista a Catherine Lacey
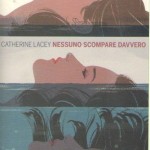 Clicca qui per leggere l’intervista a Catherine Lacey, autrice di “Nessuno scompare davvero” (Edizioni SUR). Articolo pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 27 giugno 2016.
Clicca qui per leggere l’intervista a Catherine Lacey, autrice di “Nessuno scompare davvero” (Edizioni SUR). Articolo pubblicato sul Quotidiano di Puglia del 27 giugno 2016.
La “pazza gioia” è donna
 Clicca qui per leggere l’articolo sul film “La pazza gioia” di Paolo Virzì. Pubblicato sul Quotidiano di Puglia il 23 maggio 2016.
Clicca qui per leggere l’articolo sul film “La pazza gioia” di Paolo Virzì. Pubblicato sul Quotidiano di Puglia il 23 maggio 2016.
Taranto da abbracciare. La recensione di “Città nascoste”
 Clicca qui per leggere la recensione di “Città nascoste – Trieste Livorno Taranto” (Exorma), il libro di Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, pubblicata sul Quotidiano di Puglia il 20 maggio 2016.
Clicca qui per leggere la recensione di “Città nascoste – Trieste Livorno Taranto” (Exorma), il libro di Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, pubblicata sul Quotidiano di Puglia il 20 maggio 2016.
La recensione del nuovo album di Vinicio Capossela
 La recensione di “Canzoni della Cupa”, nuovo album di Vinicio Capossela, pubblicata sul Quotidiano di Puglia del 18 maggio.
La recensione di “Canzoni della Cupa”, nuovo album di Vinicio Capossela, pubblicata sul Quotidiano di Puglia del 18 maggio.
La recensione di “La carne”, romanzo di Cristò
 Clicca qui per leggere la recensione, apparsa sul Quotidiano di Puglia del 21 aprile, dell’ultimo romanzo di Cristò, intitolato “La carne”
Clicca qui per leggere la recensione, apparsa sul Quotidiano di Puglia del 21 aprile, dell’ultimo romanzo di Cristò, intitolato “La carne”
L’intervista a Franco Causio
 Clicca qui per leggere l’intervista a Franco Causio, pubblicata sul Quotidiano di Puglia lo scorso 17 gennaio.
Clicca qui per leggere l’intervista a Franco Causio, pubblicata sul Quotidiano di Puglia lo scorso 17 gennaio.
“Loro chi?”. Cinema e Puglia, il truffatore vende sogni
 Clicca qui per leggere l’articolo sul film “Loro chi?”, apparso sul Quotidiano di Puglia.
Clicca qui per leggere l’articolo sul film “Loro chi?”, apparso sul Quotidiano di Puglia.
“Belli di papà”: il campanilismo non serve
 Clicca qui per leggere il commento di Giuliano sulla polemica scoppiata a Taranto intorno al film “Belli di papà”. Articolo uscito con richiamo in prima pagina sull’edizione di Taranto del Quotidiano di Puglia del 12 ottobre.
Clicca qui per leggere il commento di Giuliano sulla polemica scoppiata a Taranto intorno al film “Belli di papà”. Articolo uscito con richiamo in prima pagina sull’edizione di Taranto del Quotidiano di Puglia del 12 ottobre.
Favonio, la poesia diventa musica
 L’articolo, apparso sul Quotidiano di Puglia del 3 novembre, dedicato all’ultimo album dei Favonio.
L’articolo, apparso sul Quotidiano di Puglia del 3 novembre, dedicato all’ultimo album dei Favonio.
Da Sanremo (sponda Tenco) a Foggia, passando per i versi di una poetessa e le voci di nove regine della musica italiana. “Parole in primo piano”, terzo album dei foggiani Favonio, ha una genesi tutta particolare. Partiamo da Alba Avesini, importante operatrice del Club Tenco e professionista dell’editoria (è stata fra l’altro la traduttrice italiana degli albi di Asterix), scomparsa dodici anni fa. Era anche poetessa, ma in incognito, finché, due anni fa, il marito Enrico de Angelis e l’amica Francesca Rizzotti, non hanno deciso di pubblicare i suoi scritti nel libro “Poesie e filastrocche” (edizioni Scripta).
E i Favonio? E’ lo stesso de Angelis, direttore artistico del Club Tenco (il Premio Tenco 2015 si è concluso lo scorso 24 ottobre) a spiegare, nel libretto di “Parole in primo piano”, come sono andate le cose: “Seguivamo questo gruppo musicale foggiano semplicemente perché sono bravi, e infatti li abbiamo anche invitati al Club Tenco. Ma c’era in loro un quid in più di umano, di amichevole, di generosamente affabile, di deliziosamente squinternato”. Segue il racconto di una villeggiatura nel Gargano e del successivo dono da parte di de Angelis di una copia del libro di Alba a un membro del gruppo.
I Favonio non conoscevano le poesie della Avesini, ma ne restano folgorati e decidono di metterne in musica e inciderne alcune. Dalle parole della Avesini traspare però una sensibilità tutta femminile, che la voce baritonale di Paolo Marrone, il frontman dei Favonio, non può rendere da sola. E così si forma una squadra di voci femminili, una per canzone, sublime contraltare per il timbro cavernoso di Marrone. Ed è una squadra d’eccezione: Alice, Rossana Casale, Patrizia Laquidara, Petra Magoni, Margot, Giovanna Marini, Momo, Erica Mou e Paola Turci.
Ne viene fuori un disco insolito, con tracce molto diverse l’una dall’altra, sia per gli accenti delle liriche (di volta in volta dolci, malinconiche, sensuali, giocose) sia per i sapori delle musiche (che spaziano dal funk al jazz alla bossanova). Chiude il disco “La canzone dei vecchi amanti” di Jacques Brel, in una traduzione inedita di Paolo Marrone e Mimmo Petruzzelli (i due membri fondatori del gruppo, che conta altri sei musicisti): in ogni loro album i Favonio inseriscono una cover, e questa è una delle canzoni che Alba Avesini scelse di far suonare durante il suo matrimonio.
La copertina dell’album è una foto di Renzo Chiesa, uno dei più affermati fotografi musicali italiani, che ritrae la veduta verso l’alto di un cortile tunisino. Di Chiesa sono anche le foto dei testi originali scritti dalla Avesini, presenti nel libretto. Da questi scatti si può notare l’abitudine che Alba aveva di “attribuire” i suoi scritti a famosi musicisti (Paoli, Tenco, Lauzi, lo stesso Brel…): un gioco in cui si sommavano l’attitudine schiva con cui si accostava alla poesia e – chissà – anche l’auspicio o il presagio che quelle parole un giorno si sarebbero trasformate in canzoni.
La recensione di “Woody” di Federico Baccomo
 Ecco la recensione del romanzo breve “Woody” di Federico Baccomo, apparsa sul Quotidiano di Puglia.
Ecco la recensione del romanzo breve “Woody” di Federico Baccomo, apparsa sul Quotidiano di Puglia.
Dopo i corrosivi romanzi “Studio illegale”, “La gente che sta bene” e “Peep Show” (tutti e tre pubblicati da Marsilio, dai primi due sono stati tratti film), Federico Baccomo cambia genere e in “Woody” (Giunti, 91 pagine) racconta con levità la storia di un cane finito nella gabbia di un canile, e delle circostanze che l’hanno portato lì. L’io narrante è il cane stesso, Woody, e il gioco è quindi quello di far parlare chi non ha voce, svelando un punto di vista candido e “altro” sulla realtà.
In questi casi, all’autore si pone subito il problema del linguaggio da adottare. Come fare esprimere pensieri complessi a una mente semplice? Come creare uno stile che sia sì originale ma che al contempo alla lunga non stanchi? Baccomo risolve il dilemma adottando una lingua piana, condita da piccole imprecisioni, avara di articoli e preposizioni come quella di certi immigrati dell’Est, e in cui Woody parla di se stesso alla terza persona (perché sono gli altri a dargli coscienza di sé, ed è dagli altri che prende anche in prestito le parole). Ma il colpo di genio sta nell’uso che l’autore fa dei due punti. Un uso smodato, creativo, volutamente improprio. Due punti frequentissimi, che ricorrono anche più volte nella stessa frase: “Ecco, Padrona: raccoglie bisogni di Woody e mette tutti dentro sacchettino! Woody: giura! Difficile credere ma: verissimo! Padrona: mette bisogni di Woody dentro sacchettino come se sono oggetti preziosi tipo: osso, e poi custodisce sacchettini in tante scatole chiamate: Appositi Cestini. Bisogni di Padrona invece: sempre in stessa scatola chiamata: Water. Cose stranissime.”
L’espediente funziona come scorciatoia sintattica, ma serve anche a colorare l’eloquio del cane di un precipuo stupore da scoperta, una tenerezza da scolaretto che espone la lezione appena imparata. Infine, i due punti fungono da intercalare, danno una metrica precisa alla lettura. Sono piccole pause, hesitation simili a quelle degli annunci automatici nelle stazioni ferroviarie, suggerendo lo stesso sforzo compilativo nella messa in fila e nell’esposizione dei pensieri.
Ma al di là del linguaggio, la felicità del risultato deriva anche dal modo – che sotto l’apparente semplicità cela uno sforzo notevole – in cui Baccomo si è calato nella testa del suo Woody cercando di guardare il mondo con i suoi occhi. E così che la museruola diventa “bicchiere con buchi”, il tacco 16 della padrona è “bastoncino tipo osso attaccato sotto il tallone” e uno dei più grandi misteri della vita è chi cambi il mondo in pochi secondi oltre le porte chiuse di un ascensore.
Conoscevamo Baccomo come brillante fustigatore delle vanità, delle avidità e delle aridità contemporanee. I suoi precedenti lavori battevano forte i tasti del sarcasmo e del grottesco, proponendo quasi sempre un io narrante “negativo”, sebbene anche un po’ vittima. In “Woody” Federico ci sorprende vestendo i panni del buono e affiancando alla consueta lucidità e all’immutato humour anche una forte e inedita dose di empatia, di sentimento. Uno scarto che va a tutto vantaggio della cifra letteraria del suo lavoro, rendendo Baccomo più scrittore e meno semplice autore.
“Woody” è una storia breve e all’apparenza semplice che riesce a racchiudere una grande ricchezza di contenuti. Per questo il riferimento a “Il Piccolo Principe” in quarta di copertina non appare fuori luogo. Con il suo quarto romanzo Federico Baccomo ha compiuto un’operazione coraggiosa, innanzitutto perché è uscito dal sentiero dei generi più battuti e poi perché scrivere una storia di buoni sentimenti senza cadere nello stucchevole è molto più difficile che fare ridere dicendo cattiverie sui cattivi. E’ un tentativo perfettamente riuscito che merita di essere premiato.
Taranto al cinema, “fascino neomelodico”. L’intervista a Giuseppe Marco Albano
 Ecco l’intervista a Giuseppe Marco Albano, regista del cortometraggio “Thriller”, apparsa sul Quotidiano di Puglia con il titolo “Taranto al cinema, ‘Fascino neomelodico’”.
Ecco l’intervista a Giuseppe Marco Albano, regista del cortometraggio “Thriller”, apparsa sul Quotidiano di Puglia con il titolo “Taranto al cinema, ‘Fascino neomelodico’”.
Il suo cortometraggio “Thriller” – storia di un ragazzino che insegue il suo sogno di celebrità sullo sfondo dei giorni caldi della vertenza Ilva – si è aggiudicato ben sessanta premi, fra cui il David di Donatello. Giuseppe Marco Albano, trentenne di Bernalda (Matera) attivo alla regia dal 2008 (nel 2010 ha vinto il Nastro d’Argento con il cortometraggio “Stand by me”) ci parla della sua carriera, di Taranto e del cinema.
Ti aspettavi un simile successo per “Thriller”? E a cosa lo attribuisci?
«Ovviamente non mi aspettavo di vincere il David di Donatello, ma devo dire che pur essendo “Thriller” figlio di un’intuizione spontanea, che metteva insieme due mie grandi passioni, ho costruito il corto cercando di includere alcuni aspetti che immaginavo sarebbero stati apprezzati dalle giurie. Mi riferisco in particolare al taglio da commedia dai toni sociali forti – ovvero ciò che ha fatto grande il cinema italiano – e il tema dell’Ilva di Taranto, di cui in quel periodo si parlava moltissimo».
Due passioni, quindi, per Michael Jackson e per Taranto. Da dove nasce quella per la città jonica?
«Per noi a Bernalda, Taranto è sempre stata la città di riferimento, molto più che Matera o Bari. E’ lì che, fin da quando ero piccolo, la mia famiglia si recava per fare gli acquisti importanti. E’ lì che ho visto il primo ipermercato della mia vita. Poi c’è il mare. Mio padre era di Brindisi, altra città costiera pugliese. Bernalda è il primo comune lucano dopo il confine con la Puglia e con la provincia di Taranto. Ricordo che quando vidi “Io speriamo che me la cavo” della Wertmuller e scoprii che la Napoli della finzione cinematografica era in realtà Taranto vecchia, fu per me un momento magico, perché capii che si poteva fare cinema anche in luoghi a me familiari. Taranto colpisce i registi e gli scrittori, credo anche per quello che io chiamo “fascino neomelodico”, cioè quella complessa struttura popolare, con aspetti anche delinquenziali, che accomuna le grandi città del Sud».
E’ stato difficile, quando hai girato “Thriller”, trovare accoglienza in questo tipo di contesto?
«Sì, soprattutto all’inizio. Taranto in quel periodo era assediata da troupe e telecamere, e fra i tarantini serpeggiava un sentimento di insofferenza verso un modo di raccontare la città spesso ispirato al sensazionalismo e alla negatività. Di fronte a queste obiezioni, io cercavo di ribattere che il mio film avrebbe avuto un taglio diverso ma, visto che il corto lo stavo ancora girando, non avevo prove per dimostrarlo! E del resto, anche una volta finito il lavoro, non sapevo come sarebbe stato accolto dai tarantini. Ma per fortuna i giudizi sono stati in massima parte positivi».
A cosa stai lavorando ora?
«Sto scrivendo un lungometraggio, una commedia interamente ambientata a Napoli che si chiamerà “Vedi Napoli e poi muori”. Sarà incentrata sugli anziani e, come “Thriller”, cercherà di toccare tematiche serie col tocco leggero della commedia. Spero di riuscire a girarlo fra la primavera e l’estate del 2016».
Da addetto ai lavori, come giudichi il momento che sta attraversando il Cinema in Puglia e Basilicata?
«La Puglia negli ultimi anni ha fatto cose straordinarie, e la piccola Basilicata sta cercando di seguirne le tracce. Si dice che non sia tutto oro ciò che luccica, ma nella fattispecie dietro la facciata c’è anche la sostanza».
Qual è lo stato di salute del sistema Cinema italiano?
«Si intravede qualcosa di positivo: stiamo assistendo a un passaggio generazionale sia a livello istituzionale che artistico, che dovrebbe portare a uno svecchiamento. Certo, fra le cose negative, vanno registrate l’esterofilia dei nostri premi cinematografici e la tendenza a confondere il cinema con gli altri media, come la tv e il web. Quando si cerca di scovare il nuovo regista di successo fra youtuber o autori di video virali, magari bravi, ma privi di una cultura cinematografica anche minima, secondo me si perde in partenza».
L’intervista a Maurizio Cotrona
 Clicca qui per leggere l’intervista a Maurizio Cotrona, apparsa sul Quotidiano di Puglia cartaceo e online, in occasione dell’uscita del suo romanzo “Primo”.
Clicca qui per leggere l’intervista a Maurizio Cotrona, apparsa sul Quotidiano di Puglia cartaceo e online, in occasione dell’uscita del suo romanzo “Primo”.
Pioggia e playoff
 L’articolo su Viterbese-Taranto apparso sul Quotidiano di Taranto il 9 giugno.
L’articolo su Viterbese-Taranto apparso sul Quotidiano di Taranto il 9 giugno.
Domenica 7 giugno, stadio Rocchi di Viterbo, 17,40 circa. Il Taranto ha appena pareggiato. Mentre le due squadre, nei pochi minuti che mancano al 90’, spremono le ultime energie nel tentativo di affondare il colpo del Ko, la pioggia si fa sempre più intensa, fulmini continui crepano il cielo cupo e tuoni simili a esplosioni coprono le urla di tifosi ormai prossimi all’afonia. Il momento è di una solennità quasi mitologica, e come certi miti è surreale e insieme emblematico. L’anima del calcio tarantino sembra essersi raggrumata lì, nelle ultime battute di una partita riacciuffata per i capelli e ancora aperta a qualsiasi possibilità. Una partita sudata e sofferta, sebbene nessuno sappia ancora esattamente a cosa serva. Una partita, infine, giocata sotto la pioggia. La pioggia che ha iniziato timidamente a cadere poco prima del gol della Viterbese, quasi a volerlo annunciare, che è proseguita impietosa lungo tutto l’intervallo e poi nella ripresa, trasformandosi infine in un temporale liberatorio dopo l’inzuccata di Pambianchi. Era quello il posto del Taranto: non certo Berlino in mondovisione, ma forse neanche lo Iacovone baciato dal sole dopo una vittoria netta. Il posto del Taranto è un campo fangoso di provincia dove un secondo o un millimetro fanno la differenza fra il trionfo e la disfatta.
La pioggia durante i playoff del Taranto non manca mai. E’ un’incredibile versione moderna della nuvoletta di Fantozzi. I playoff si giocano fra maggio e giugno, un periodo in cui è più probabile beccarsi un’insolazione che farsi una doccia con i vestiti addosso. Eppure, da Lanciano a Vercelli, passando dal famigerato Taranto-Catania, da Taranto-Rende del 2006 e dall’incredibile beffa del Flaminio, di acqua sulle nostre teste ne è caduta in abbondanza. E’ un surplus di sofferenza, una certificazione di anormalità cui forse ci stiamo iniziando ad abituare: rende più eroiche le vittorie e in fondo anche le sconfitte. E’ qualcosa che si ricorda e si racconta con piacere, perlomeno una volta smaltito il raffreddore.
Durante gli ultimi minuti di Viterbo – con l’incertezza sul risultato che regna sovrana – c’è da scommettere che siano in tanti sugli spalti a essere contenti così, a prescindere da come andrà a finire, oppure a chiedersi, con una sorta di masochistica soddisfazione, in quale modo assurdo arriverà stavolta l’immancabile mazzata (2-1 della Viterbese al 95’? Sconfitta ai rigori? O ancora – pericolo non ancora scongiurato – arrivare per una volta in fondo ai playoff ma rimanere ugualmente in D per qualche cervellotico nodo regolamentare?). Perché dopo tutto, è questo che cerchiamo: emozioni. Emozioni e piccole grandi gioie, anche estemporanee, eventualmente pure slegate da risultati, graduatorie e punteggi.
Poi sono arrivati i rigori, una modalità di sofferenza relativamente rara nella pur ricchissima casistica rossoblu. La fine è nota: i nostri, freddissimi, segnano; loro ne mandano alle stelle due su quattro. A quel punto tutti i pensieri sono scomparsi, ed è rimasto solo spazio per una gioia pura. Minuti di abbandono in cui ci si dimentica di tutto (e di cui fortunatamente si conserva un ricordo abbastanza confuso, a patto di non essere immortalati in un video amatoriale…), e in cui abbracciare degli sconosciuti urlanti sembra perfettamente normale, anzi necessario. Sarà anche solo una partita di calcio, ma ogni tanto è bello, e forse anche salutare.
Poi però quell’attimo finisce, e si ritorna all’ordinarietà. La vita va avanti, dentro e fuori dai campi di calcio. C’è da scommettere che per domani, sulla riviera ligure di levante, sia prevista nuvolosità variabile.
Tutto il fumo che ci hanno venduto sull’Ilva. La top ten delle bufale
 Clicca qui per l’articolo su Globalist.it.
Clicca qui per l’articolo su Globalist.it.
A Taranto la laurea in “Mali Culturali”
 Pubblicato sul Quotidiano di Taranto del 21 maggio.
Pubblicato sul Quotidiano di Taranto del 21 maggio.
Se l’Ateneo di Bari chiude il Corso di Laurea in Beni Culturali di Taranto non è certo per una forma di accanimento verso il territorio jonico, ma piuttosto per questioni economiche che hanno cause e conseguenze più generali. Tuttavia, in una città che ha bisogno di ripensarsi, che non vuole essere più (solo) industriale e che proprio nella Cultura e nella valorizzazione dei propri beni sembra aver individuato una delle poste su cui puntare, la notizia di questa ennesima soppressione universitaria pesa come un macigno, e impone una riflessione molto seria. Anche perché se l’università piange, gli altri prestigiosi centri di istruzione non ridono: il destino dell’Istituto Musicale Paisiello (quasi un secolo di storia, parificato ai conservatori) è sempre in bilico, mentre la sede storica dell’Archita (uno dei ginnasi più antichi d’Italia) langue da anni fra le impalcature proprio al centro della città.
L’unico aspetto positivo in questa vicenda – a volerne trovare uno – sono le 8mila firme raccolte fra i cittadini nel tentativo di scongiurare la chiusura del corso di laurea. Vuol dire che perlomeno la perdita viene considerata tale, e che qualcuno ha saputo convogliare l’opinione pubblica in un’iniziativa concreta, sebbene infruttuosa. Magra consolazione? Può darsi, ma ugualmente un fatto da non dare per scontato, visto l’orribile silenzio che ha accompagnato, in un passato anche recente, “scippi” e occasioni perse dello stesso genere di questa ultima.
Il fatto è che di istruzione in materia di beni culturali e turismo qui ci sarebbe bisogno, eccome. In che modo vengono trattati, infatti, i nostri beni culturali? Prendiamo il Marta. Fiore all’occhiello, almeno a parole, dell’offerta non solo cittadina ma anche regionale. Che però in città viene penalizzato da una gestione – diciamo così – non fra le più dinamiche, mentre negli aeroporti più vicini – che pure pullulano di foto e pannelli sulle attrattive del territorio – del museo archeologico tarantino non si trova alcuna0 traccia.
Prendiamo poi le aree militari in odore di dismissione, dai pezzi di Arsenale e Ospedale alle Isole Cheradi: in quanti le considerano davvero dei beni culturali e delle opportunità di sviluppo?
Prendiamo infine la Città Vecchia: crolli e abbandono quasi ovunque; i pochi spazi recuperati sono poco pubblicizzati, sottoutilizzati e gestiti solitamente in proprio – quindi in perdita – dal Comune. A Matera, Capitale Europea della Cultura nel 2019 – ricordate? Avevamo partecipato anche noi, con una proposta tardiva e velleitaria – le ristrutturazioni susseguitesi negli ultimi anni hanno visto fondazioni e associazioni partecipare prima nella progettazione e poi nella gestione di spazi e attività, garantendo vivacità e sostenibilità economica.
E allora è proprio da qui che si deve ripartire. Da una partnership in cui il pubblico mette a disposizione ciò che ha (risorse, sebbene in quantità sempre minori, patrimonio edilizio e naturale e potere decisionale) e le piccole imprese, le associazioni giovanili, il volontariato, insomma tutta quella parte viva di città che in questo momento ha più idee che possibilità di metterle in pratica, offrono competenze, voglia di fare e spirito imprenditoriale. Ma, come scritto altre volte, questo dialogo fra istituzioni e società a Taranto è davvero molto difficoltoso. E forse è anche per questo – che possiamo definire un vero “male culturale” – che i corsi di laurea e le occasioni di rilancio si allontanano da questa città.
Il brand di Taranto? La trasformazione
 Articolo uscito sul Quotidiano di Puglia nei giorni scorsi.
Articolo uscito sul Quotidiano di Puglia nei giorni scorsi.
Sabato 28 marzo presso l’Arsenale (Sala a Tracciare) si terrà il convegno “La Valorizzazione Culturale e Turistica dell’Arsenale di Taranto”, a cura della Fondazione Michelagnoli. Si tratta di un tema che, in modo curioso, è ben poco presente nel dibattito sul futuro della città, persino nelle parole dei più convinti assertori della cultura e del turismo come volano per il rilancio. Eppure la possibile restituzione di alcune aree militari rappresenta un’occasione enorme: dove altro, se non a Taranto, si dispone di un gigantesco e inesplorato museo a cielo aperto di archeologia industriale in pieno centro? Dove c’è un affaccio a mare ancora tutto da scoprire? L’abbattimento di parte del Muraglione aprirebbe delle prospettive simili a quelle viste a Genova con il recupero del Porto Antico: qualcosa in grado di cambiare il profilo fisico e la vocazione stessa della città, ma in perfetta coerenza con il suo passato recente.
Taranto non è solo Magna Grecia o Settimana Santa. Taranto non è un solo periodo storico, magari lontano secoli o millenni. A rendere speciale questa città è la sua storia nel complesso, l’intricato sovrapporsi di vicende diverse, di cui è la città stessa a doversi fare museo. Ecco: pur rendendo onore a ogni epoca della sua storia, sarebbe bello se il “brand” del rilancio di Taranto, in un momento così particolare, fosse proprio la trasformazione. E allora piuttosto che negare, cancellare o nascondere la storia di questa città nell’ultimo secolo e mezzo, sarebbe molto meglio raccontarla, e attraverso la “museificazione” e il riuso delle sue strutture, suggerire l’idea che appunto di storia in buona parte si tratta, e che altre storie si stanno scrivendo a partire da oggi. Sarebbe un errore madornale – oggi che certi crimini contro la salute e l’ambiente sono definitivamente venuti alla luce – accomunare in un indistinto sentimento di disprezzo gli effetti nefasti che l’industria (anche quella militare, altroché) ha avuto sulla città e le testimonianze storiche, architettoniche e culturali con cui la stessa industria ha lasciato la sua impronta su Taranto.
Il 2015 è l’Anno Europeo del Patrimonio Industriale. Ma a riportare alla ribalta il tema della restituzione e valorizzazione delle aree militari – di cui si discute da diversi anni ma sempre sottotraccia, in sordina – hanno contribuito soprattutto due novità legislative: la recente legge regionale “Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale” e l’articolo 8 della legge 4 marzo 2015 n. 20, da molti detta la settima “Salva-Ilva”. Quell’articolo riguarda gli interventi di valorizzazione culturale e turistica da realizzarsi a Taranto, con particolare riferimento alla Città Vecchia e all’Arsenale. È in sostanza un atto di indirizzo, una specie di “suggerimento” dello Stato, non essendo previste risorse aggiuntive ma venendo solo indicato, come possibile finanziamento, un fondo già esistente e destinato al Mezzogiorno. Ci si potrebbe chiedere se per due linee di intervento apparentemente ovvie – puntare su Città Vecchia e Arsenale a fini culturali e turistici – la città avesse bisogno di imbeccate esterne. Alla prova dei fatti, bisogna concludere che la risposta è affermativa. Infatti, la Città Vecchia, rivitalizzata molto più dai privati che dal pubblico, langue fra crolli e incuria (emblematico il recente caso degli arredi antichi rubati e finiti ad alimentare i falò di San Giuseppe) mentre il baricentro della città si allontana sempre più dalla sua culla millenaria, condannando al declino non solo l’Isola ma ormai anche il Borgo. E l’archeologia industriale, come detto, è restata finora materia quasi esclusiva di esperti e iniziati. Un argomento di nicchia, ampiamente sottovalutato. C’è da augurarsi che il convegno di sabato possa far capire ai cittadini quali potenzialità si celano dietro al Muraglione.
I talebani dell’ignoranza e la colpevole indifferenza
 L’articolo apparso il 24 marzo sul Quotidiano di Taranto. Riflessioni sugli arredi di un palazzo storico trafugati e bruciati in un falò di San Giuseppe.
L’articolo apparso il 24 marzo sul Quotidiano di Taranto. Riflessioni sugli arredi di un palazzo storico trafugati e bruciati in un falò di San Giuseppe.
Spariamola grossa: gli antichi mobili sottratti da un palazzo nobiliare in Città Vecchia e bruciati nel falò di San Giuseppe fanno (o dovrebbero fare) lo stesso effetto terrificante dell’abbattimento delle statue a Mosul da parte dell’Isis o del rogo di libri a opera dei Nazisti nel 1933. La differenza è una sola: se ad armare la mano di barbuti e camicie nere è stata la fede cieca in principii folli, a casa nostra il delitto non ha alcuna radice ideale. Si è consumato così, senza un vero motivo, forse per pura stupidità. Niente guerre di religione o miti della razza, qui: da noi impera la dittatura dell’ignoranza e dell’incuria. Che forse è ancora peggiore.
Di Taranto vecchia sono i colpevoli dello sfregio, di Taranto vecchia sono anche i ragazzi (dell’associazione Obiettivo Borgo Antico) che l’hanno denunciato. Nell’attribuzione delle colpe non ci aiuta la divisione fra quartieri degradati e “città bene”. Così come false e fuorvianti sono tante divisioni in cui spesso finiamo per cadere: fra ricchi e poveri, fra ladri e onesti, fra destra e sinistra, fra operai e ambientalisti. A Taranto la vera divisione è un’altra. Da un lato ci sono quelli che sanno, e se non sanno si informano. Quelli che alla città tengono, e si danno da fare per difendere il buono che esiste e per costruire qualcosa di nuovo. Dall’altro lato c’è chi non sa, oppure sa e se ne frega, chi distrugge o lascia che vada tutto a rotoli. E se non ha senso fare manichee separazioni fra buoni e cattivi (probabilmente nella maggior parte dei tarantini c’è qualcosa di entrambe le categorie, così come peraltro accade in qualsiasi città) è anche vero che Taranto è in un momento di crisi (che vuol dire anche trasformazione, opportunità). E nelle crisi le posizioni si polarizzano: la gente è chiamata a schierarsi, e non schierarsi vuol dire essere arruolati d’ufficio nell’esercito dei cemmenefuttisti.
Chi sono allora i talebani dell’ignoranza? Innanzitutto chi si è macchiato del misfatto: al netto delle possibili attenuanti (erano ragazzini, non sapevano, nessuno ha insegnato loro ad amare il posto in cui vivono…) un nocciolo di responsabilità individuale va sempre conservato. L’educazione passa anche dalla stigmatizzazione di un comportamento sbagliato. E di comportamenti sbagliati, il giorno di San Giuseppe, ce ne sono stati a bizzeffe (ecco gli altri colpevoli). A partire dalla razzia indiscriminata di legno: rubare materiale da strutture pubbliche o private è un reato anche se non si tratta di arredi del Settecento. Cosa dire poi della totale anarchia in cui vengono accesi i falò, senza alcuna precauzione di sicurezza? Sarebbe così difficile per il Comune organizzare queste celebrazioni in una cornice controllata? Anche perché – particolare non trascurabile – nelle cataste date alle fiamme finisce materiale che sviluppa fumi nocivi (e qualcuno di sicuro dirà che con tutto l’inquinamento industriale che grava su Taranto non ha senso preoccuparsi di quattro falò: ragionamento cemmenefuttista anche questo, perché sono proprio il lassismo quotidiano generalizzato e la mancanza di una cultura della salute e dell’ambiente ad aver permesso agli inquinatori di fare impunemente i loro comodi per tanto tempo).
Ma il punto in fondo è un altro, ed emerge da una semplice constatazione: se il deprecabile episodio non fosse stato denunciato dai ragazzi di Obiettivo Borgo Antico, della sottrazione di materiali preziosi non si sarebbe accorto nessuno. I “tesori” si trovavano in uno dei tanti palazzi storici abbandonati, pericolanti e incustoditi dell’Isola. Quell’Isola che qualcuno con caparbietà cerca di far tornare a nuova vita, ma che è schiacciata in una morsa mortale dal disprezzo di molti suoi abitanti e dalla pochezza di chi per ruolo istituzionale dovrebbe prendersene cura. Nessuno era a conoscenza di quei “tesori” prima che venissero distrutti. Nessuno è riuscito a preservarli e a valorizzarli. Forse quel falò, come un’eutanasia, ha solo accelerato una fine comunque inevitabile.
Il commento al settimo decreto Salva-Ilva
 Ecco un commento di Giuliano, apparso sul Quotidiano di Puglia del 9 gennaio, sul settimo decreto legge “Salva Ilva”.
Ecco un commento di Giuliano, apparso sul Quotidiano di Puglia del 9 gennaio, sul settimo decreto legge “Salva Ilva”.
Molto è stato detto e molto ancora si dovrà dire sull’impianto generale del settimo Decreto Salva Ilva (opportunità, fattibilità e reali obiettivi della nazionalizzazione a tempo). Ora che – finalmente! – il testo è stato pubblicato, altre e più specifiche considerazioni vanno fatte sul contenuto delle misure. Che sono tante e controverse: se si vuole capirle davvero, conviene attenersi al testo e analizzarlo al meglio. Difficile racchiudere una trattazione organica del decreto in un solo articolo. Ci si limiterà dunque qui ad approfondirne solo alcuni aspetti.
Una prima frase in un certo senso rivelatrice dello spirito di questo provvedimento si trova già nella sua premessa, cioè in quella parte degli atti legislativi che solitamente, in una lettura veloce, si salta a piè pari. Il Presidente della Repubblica, si scrive, emana il decreto considerando, fra l’altro, “che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell’ambiente e della salute”. Questo enunciato, che nelle intenzioni di chi l’ha scritto andrebbe probabilmente letto come espressione del principio secondo cui se l’Ilva non produce non ci sono i soldi per risanarla, suona in realtà come la dichiarazione dell’unico reale obiettivo del decreto (la continuità produttiva), coperta dalla piccola e pudica foglia di fico della protezione di ambiente e salute. Alla luce di quanto accaduto finora, infatti, non è emerso alcun nesso fra la continuità produttiva – disperatamente perseguita dagli ultimi tre Governi – e il risanamento ambientale, tanto più che quando la magistratura ha provato a mettere le mani sui proventi della produzione Ilva, è stato proprio il Governo a sbloccare il sequestro. L’unico nesso fra produzione e risanamento resta quindi quello ovvio di segno negativo, dovuto alla perdurante attività di una fabbrica che a tutt’oggi inquina.
E ciò sarà sempre più vero considerando che il risanamento – peraltro parziale e discutibile – promesso lungo l’asse AIA-Piano Ambientale, continua a subire ritardi su ritardi. Ricordiamo che L’AIA 2012 prevedeva che la maggior parte delle prescrizioni venisse posta in essere fra gli ultimi mesi del 2012 e i primi del 2013, e che altre prescrizioni, le più complesse, venissero portate a compimento fra il 2014 e il 2015. E’ intervenuto poi il Piano Ambientale a rimodulare le scadenze fra la metà del 2015 e la fine del 2016, spostando in avanti la tempistica degli interventi più costosi e importanti (primo fra tutti la famosa copertura dei parchi minerari). Nel nuovo decreto leggiamo che il Piano Ambientale “si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell’80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data”. Attenzione quindi: se l’Italiano non è un’opinione, entro luglio 2015 non deve essere realizzato l’80 per cento delle prescrizioni del Piano Ambientale, ma l’80 per cento di quella parte di misure (le meno complesse) che erano state calendarizzate a quella data. Quindi una percentuale del totale più bassa dell’80 per cento. Quanto alle altre fondamentali prescrizioni, scompare qualsiasi limite. Il Piano Ambientale risulta attuato anche in loro mancanza, e il nuovo decreto dispone solo che entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell’ambiente e all’ISPRA una relazione sull’osservanza delle prescrizioni del Piano Ambientale, e che con apposito decreto del Presidente del Consiglio è stabilito il termine ultimo per l’attuazione di tutte le altre prescrizioni. Dunque nessun limite di tempo per il momento, ma solo la previsione di un nuovo decreto da emanare non prima del 2016. Facile prevedere che le scadenze del Piano Ambientale slittino ancora più avanti. Ma in fondo tutto ciò conta relativamente perché, stante l’insufficienza delle risorse economiche stanziate, è ancora più facile prevedere che queste prescrizioni non verranno mai rispettate. I bambini di Taranto, tanto cari al Presidente Renzi, ringraziano sentitamente.
Atletico Roma-Taranto su Alchimie
 E’ online sul sito di Alchimie, “L’amara illusione. Atletico Roma-Taranto”, pezzo scritto a quattro mani da Valentina Pellegrino e da Giuliano, dedicato alla famosa semifinale playoff del giugno 2011. Clicca qui per leggere.
E’ online sul sito di Alchimie, “L’amara illusione. Atletico Roma-Taranto”, pezzo scritto a quattro mani da Valentina Pellegrino e da Giuliano, dedicato alla famosa semifinale playoff del giugno 2011. Clicca qui per leggere.
